 Dal Nostro Redattore Difesa
Dal Nostro Redattore Difesa
Antonio Mazzeo
28 novembre 2025
Nonostante gli screzi e le tensioni (più formali che sostanziali) dovute all’irrisolto caso di Giulio Regeni, la collaborazione militare tra Italia ed Egitto prosegue e si rafforza imperterrita. A metà novembre, nell’ambito degli scambi bilaterali di esperienze e conoscenze nel settore dell’artiglieria controaerea, si è conclusa la visita della delegazione di militari appartenenti alla difesa aerea delle forze armate egiziane, con attività dimostrative organizzate dal 17° Reggimento Artiglieria Controaerei “Sforzesca” di stanza a Sabaudia (Latina).
Delegazione egiziana
“Il comandante del Reggimento, colonnello Nicola Capozzolo, ha ricevuto la delegazione e illustrato le capacità esprimibili dalla specialità controaerei dell’esercito”, rende noto lo Stato Maggiore della Difesa.

L’attività è proseguita con la visita della caserma “Santa Barbara”, sede del Comando dell’Artiglieria controaerei, dove gli ufficiali egiziani hanno assistito alle attività addestrative dello “Sforzesca”. Successivamente la delegazione nel vicino poligono di tiro di Foce Verde, dove si è svolta un’esercitazione militare con l’impiego di mini e micro aeromobili a pilotaggio remoto.
“La visita si è conclusa con il saluto del generale di brigata Mattia Zuzzi, comandante della specialità controaerei, che ha auspicato l’intensificazione delle attività di cooperazione bilaterale”, spiega lo Stato Maggiore italiano.
La missione degli ufficiali egidiziani nella provincia di Latina è avvenuta alla vigilia di EDEX 2025,una delle più grandi esposizioni di sistemi bellici mai realizzata in africa e nell’area mediorientale.
EDEX 2025, Cairo
La kermesse è prevista dall’1 al 4 dicembre al Cairo e sarà inaugurata dal presidente Abdel Fattah Al Sisi, Comandante supremo delle forze armate egiziane.

Ad EDEX 2025 parteciperanno le maggiori aziende del comparto militare industriale italiano. Tra gli espositori “eccellenti” spiccano le holding a capitale statale Fincantieri SpA (gold sponsor di EDEX 2025) e Leonardo SpA (leading brand dell’esposizione). Ci sono poi ELT Group (Elettronica SpA di Roma), C.E.I.A. SpA di Arezzo, Panaro di Modena e il maggiore consorzio europeo produttore di sistemi missilistici, MBDA (platinum sponsor), di cui Leonardo controlla il 25% del capitale azionario.
Ministro Difesa al Cairo
Il 2025 ha segnato il rafforzamento delle relazioni militari industriali tra Italia ed Egitto. Il 30 e 31 luglio il ministro della Difesa Guido Crosetto ha effettuato una visita ufficiale nello Stato nord africano, incontrando il presidente Abdel Fattah Al-Sisi e il ministro della Difesa e Comandante in capo delle forze armate, generale Mageed Saqr.
Dall’1 al 10 settembre, nelle acque antistanti la città di Alessandria si è svolta invece Bright Star 25, una grande esercitazione militare cui hanno partecipato le forze armate di 43 Paesi, 30 in qualità di osservatori e 13 impegnati direttamente nell’esercitazione: tra questi spiccano Stati Uniti, Egitto, Arabia Saudita, Qatar, Grecia, Cipro ed Italia.
Bright Star 25
A Bright Star 25, la marina militare italiana ha schierato l’unità d’assalto anfibio multiruolo “Trieste”, la fregata missilistica Fremm “Fasan”, nave ammiraglia dell’operazione Mediterraneo Sicuro e alcune unità della Brigata “San Marco” di Brindisi.
Le attività della Bright Star sono state condotte in due fasi: la prima, dall’1 al 6 settembre, in porto ad Alessandria d’Egitto, con incontri e conferenze su temi come la guerra elettronica, la cyber security, le attività anfibie, le procedure di abbordaggio, le minacce asimmetriche.
La seconda fase ha preso il via il 7 settembre con quattro giorni di intense attività addestrative in mare aperto con simulazioni di lotta anfibia, anti-aerea e subacquea, Electronic Warfare Exercise, prove di tiro in poligono.
Antonio Mazzeo
amazzeo61@gmail.com
Vuoi contattare Africa ExPress? Manda un messaggio WhatsApp con il tuo nome e la tua regione (o Paese) di residenza ai numeri
+39 345 211 73 43 oppure +39 377 090 5761
Ci si può abbonare gratuitamente ad Africa Express sulla piattaforma Telegram al canale https://t.me/africaexpress
e sul canale Whatsap https://whatsapp.com/channel/0029VagSMO8Id7nLfglkas1R


 Africa ExPress
Africa ExPress






 Speciale per Africa ExPress
Speciale per Africa ExPress
 Speciale per Africa ExPress
Speciale per Africa ExPress

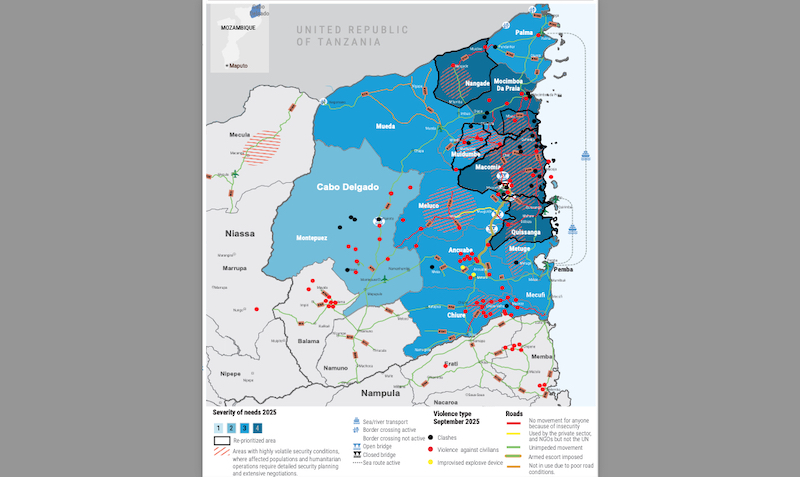
 Africa ExPress
Africa ExPress




